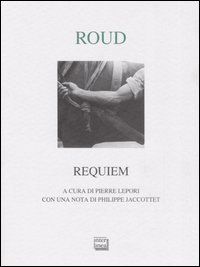 Gustave Roud, Requiem e altre prose poetiche, introduzione di Philippe Jaccottet, traduzione di Pierre Lepori, Novara, Interlinea, 2008
Gustave Roud, Requiem e altre prose poetiche, introduzione di Philippe Jaccottet, traduzione di Pierre Lepori, Novara, Interlinea, 2008
Per la prima volta in Italia le poesie del massimo poeta francese svizzero contemporaneo dopo la sua consacrazione in Francia presso Gallimard. Il volume comprende gli scritti più intensi di un’opera raffinata, che vuole comunicare «in sordina, ai margini, ma che è viva», come scrive Philippe Jaccottet nell’introduzione.
Le Edizioni Interlinea portano per la prima volta in Italia l’opera di Gustave Roud, massimo poeta della letteratura romanda contemporanea, morto nel 1976 e vissuto quasi ininterrottamente nel paese contadino di Carrouge, nelle campagne dell’Haut Jorat, conducendo una vita semplice e volontariamente lontana dagli ambienti letterari. La sua produzione poetica è rimasta per troppo tempo marginale, nel nostro paese in gran parte sconosciuta, nonostante l’indiscutibile valore artistico, la portata assoluta della sua ricerca, la potenza simbolica di una parola che, sul modello di Novalis, è capace di risvegliare l’incantesimo nella natura assopita dall’irreversibilità del tempo.
È proprio quel paesaggio campestre, nel quale trascorrerà la vita intera, ad offrire a Roud la sua materia poetica: gli alberi e i villaggi spersi, le vie sotto i cieli rosati, le colline, il vento, i contadini piegati sotto il sole, i prati «di fiori maturi» e le distese di spighe che sommergono l’uomo… ogni cosa è sotto il dominio dei giorni, delle stagioni, eppure capace di rivelare al poeta illuminato una realtà altra, un mondo jamais vu, un paradiso terrestre che rivendica, nonostante la potenza ascensionale della prosa, un’immanenza che rende quell’absolu mallarmeiano tutt’altro che inaccessibile.
Roud ha assistito con uno «sguardo puro» allo spalancarsi delle porte di un giardino dei miracoli, sottratto alla tirannia del tempo, dove ogni cosa è immobile, eterna, realmente viva; è il luogo, infine, dove si compie la comunione di Terra e Cielo. Ma questo universo dato si rivela per il poeta la felicità estrema e la più atroce condanna alla solitudine: Roud deve divenire un esule, un camminatore alla ricerca di quel paradiso dalla cui contemplazione, una volta concessaglisi, non può più astenersi. Il poeta ha bisogno di ripetere la sua esperienza mistica, superato quel varco montaliano non può far altro che desiderare solo e unicamente quella realtà altra che sente come predestinata all’umanità e che è qui, terrena, possibile: Roud cita San Francesco d’Assisi e come scrive Keller «ce n’est donc nullement par une ascension […] qu’il faut chercher l’accès à l’éternel: […] c’est plutôt par une permanence obstinée».
Qual è dunque il ruolo della poesia in questa ricerca del paradiso perduto e ritrovato sulla terra stessa? Roud predilige la prosa poetica al verso, iscrivendosi nella tradizione del simbolismo francese di fine ottocento, recuperando per la sua parola quello stesso potere visionario delle Illuminations del veggente-Rimbaud, capace di trascendere e trasfigurare la realtà stessa attraverso la sua interpretazione simbolica. È proprio grazie alla poesia che l’autore rievoca e ricrea continuamente quel miracolo che gli aveva svelato un altro mondo. Il lavoro complesso ed eccezionale che Roud svolge sul linguaggio è il tentativo inesausto di risvegliare ogni cosa, dominata dal tempo, alla sua vera ed eterna esistenza. Da qui deriva la grandezza, il potenziale inesauribile della sua poesia.
Il volume a cura di Pierre Lepori, traduttore rivelatosi all’altezza nel suo arduo compito, raccoglie l’Addio, prima opera di Roud, composta nel 1927, dove compare il personaggio di Amato, fondamentale in tutta la produzione successiva. Egli rappresenta il contadino per antonomasia, che per mezzo di un’instancabile vita attiva sigilla il più perfetto accordo fra uomo e terra: si tratta di una felicità folle che il poeta non può che contemplare e amare con ogni sua forza, prima di restituirsi al suo necessario esilio nella notte, vittima di una solitudine ineliminabile.
In Per un paradiso (1932), Amato diviene l’uomo puro, «l’uomo di carne e che accetta la sua carnalità, ma nel contempo d’una trasparenza di cristallo. Plasmato realmente dalle mie stesse impossibilità». È lui che accompagna il poeta, disorientato sulla sua stessa identità che solo la memoria sembra tenere insieme, sulla soglia della stanza notturna dove attenderà l’alba e lo svelarsi del paradiso, di cui diviene tramite nella sua «innocenza perfetta». Eppure, ancora una volta, egli dovrà partire: «Un uomo ha fatto schiudere in me questo paradiso umano che giace sparso nel nostro corpo, nel nostro cuore, con la sua sola presenza. Se la mia gioia finisce, se l’universo attorno a me ritrova la sua incoerenza primigenia, se d’un colpo richiamo con sorde, pavide delizie, la nuvola, l’ombra, la notte, a chi invano affidare la mia collera? Nessuno forse ha il diritto di guardar vivere una vita, sia pur perfetta. Eravamo nati per la contemplazione, ma qualche cosa d’altro ci è imposto senza scampo. Per questo dovrò partire».
La Scena che segue è una vera e propria dichiarazione di poetica, un piccolo dramma dove un poeta, seduto alla tavolata di una festa paesana che lentamente si spegne, assieme ad Amato addormentato e ad una coppia che non può ascoltarlo né vederlo, esplica tutti i silenzi del mondo, dice ciò che non è stato detto nella sua «solitudine popolata di passioni»: «Tutta l’impresa del mio amore è di far nascere, lontano dalle tempeste del tempo, frase dopo frase, un’immensa nuda distesa su cui un paese intero si china, per riconoscervi il suo volto».
Chiudono la raccolta l’Accecamento (breve componimento del 1966) e Requiem (1967), ultima opera dell’autore, che ideologicamente richiude il cerchio. Si tratta di un lungo appello rivolto alla madre morta, perché possa rivelarsi a lui nuovamente, come già una volta aveva fatto, lasciandogli udire la sua voce. Messaggeri di questa comunicazione, che squarcia le regole del tempo, sembrano essere gli uccelli con i loro canti, ed in particolare una rondine, che lo guiderà nel luogo in cui «l’illuminazione di un istante l’ha rivelato a sé stesso», mostrandogli che non esiste più quell’altrove tanto bramato: «E non ci sarà mai più, nel cuore del tempo se sai fartene carico e lo raccogli in te in una suprema purificazione. E colei che tacque, come raccolta nell’ombra di un infrangibile sonno più potente dei vostri due cuori, è lei che adesso potrai raggiungere».
Giuliana Altamura, « Nokoss » (06.11.2007)
Questo volume presenta per la prima volta al pubblico italiano la traduzione con testo a fronte dell’opera poetica di Gustave Roud (1897-1976) Si tratta di una raccolta di prose poetiche scritte tra il 1927 ed il 1967, il cui sfondo paesaggistico rimane sempre rappresentato dalle colline dell’Haut-Jorat, e i cui personaggi rimangono sempre quei contadini che tanto bene simbolizzano l’armonia tra uomo e natura. Così in Année (Essai pour un paradis, 1932) il poeta scruta da lontano i movimenti del contadino Aimé/Amato: «Aimé fauche sou la pluie, vêtu d’un vieil habit couleur terre. IL fait sombre et triste. Oh que l’ancienne solitude, celle d’avant, est prompte à réapparaître dès que cet homme se détourne, repris par son travail ! Quel bonheur redevient ce jardin perdu, cerné par l’angoisse grandissante, comme ces haies d’un an à l’autre élargies qui chassent devant elles l’herbe et les fleurs» / «Amato falcia sotto la pioggia, protetto da un abito vecchio color terra. Fa buio e triste. Oh come l’antica solitudine, quella di prima, riappare prontamente non appena quest’uomo si volta, assorbito dal lavoro! La mia gioia ridiventa quel giardino perduto, stretta dall’angoscia che cresce, come le siepi che di anno in anno si allargano, scacciando davanti a sé l’erba ed i fiori»). La vita del contadino diventa l’immagine paradigmatica delle vita serena, scandita dalla stagioni naturali, tanto agognata dal poeta segnato dalla sua diversità e dalla solitudine.
Lungi dall’essere una poesia puramente descrittiva, quella di Roud diventa il luogo d’elezione per la trasfigurazione della realtà contingente in realtà metaforica, ed il simbolo della solitudine dell’erranza della condizione umana. Innanzitutto, erranza metafisica di un essere in cerca di Assoluto. Poi anche erranza trasfigurata, poiché il poeta ha quasi sempre vissuto a Carrouge, dopo la laurea in lettere conseguita a Losanna. Erranza anche di uno spirito che sembra seguire nei minimi movimenti il moto impercettibile dei colori, delle ombre, delle stagioni. Roud dirà «la lumière change comme une voix. Elle n’est plus le témoin sans force d’une agonie» / «la luce cambia come una voce. Non è più testimone esausta di un’agonia», Requiem, 1967). Infine erranza di una mente che spazia in una natura antropomorfica.
La lingua stessa di Roud è, citando Lepori, «come l’onda (houle), quella del vento sulla segale o il trascolorare delle ombre sulla campagna (…): musicale e a tratti sontuosa, ma in costante sovversivo movimento». La parola, al pari della natura descritta, si spiega così in un movimento musicale e al tempo stesso malinconico, capace di fare entrare il lettore in quel mondo arcaico e mitico della natura e dei contadini che la abitano, e facendogli anelare quel paradiso.
Vanesse Kamkhagi, “Testo a Fronte”, II, 2007.

