Nuvole quasi messicane, rumorio di camion, rimorchi, merci. E la grande croce a cattedrale del Mall. Strano che nessun vigile si sia fatto avanti, sembra davvero che non l’abbiano notato. In altri casi simili, prima passavano, poi ti notavano, poi chiedevano e infine con insistenza o cortesia facevano in modo che tu ti sentissi osservato, malvenuto. Eri pregato di levare le tende. Invece questa volta era venuta solo a più riprese una donna delle pulizie obesa, tutta bardata in una tenuta azzurrina che le fasciava i fianchi, una mama antillese o haitiana, che snocciolava un bizzarro flusso di lamenti e risate, una lingua che gli era sembrata improbabile, a cui si era abituato.

Sei mesi (2022-28)
Il progetto Sei mesi prevede sei volumi di trenta racconti ognuno: lontanamente ispirato, si parva licet, alle Novelle per un anno di Pirandello (opera cardine per le sue implicazioni sociali e d’invenzione linguistico-narrativa), s’iscrive nella tradizione – oggi un po’ negletta – della novellistica italiana novecentesca, con particolare passione per le opere di Goffredo Parise (Sillabario), Natalia Ginzburg e Claudio Piersanti (L’amore degli adulti).
L’obiettivo è di comporre racconti rapidi nello svolgimento (3-5 pagine), stilisticamente liberi (e a volte sperimentali), centrati sul realismo ma con sforamenti surreali e comici; e una dose voluta di melodramma. L’altro grande modello è americano: Fitzgerald, Chever, Leavitt, Cameron. Dovrebbe poterne uscire una sorta di cartografia sentimentale della nostra epoca, dei suoi amori, dei suoi generi fluidi e delle sue disillusioni, in una prospettiva chiaramente queer. Tre volumi sono già conclusi. Il progetto ha ricevuto finora il sostegno del Premio Lilly Ronchetti 2024 , con una borsa di scrittura e un soggiorno nell’Atelier parigino dell’A*dS (Associazione degli autori e delle autrici in Svizzera). Alcune novelle sono state anticipate su riviste e giornali (cf. infra) e in linea (Giornate letterarie di Soletta, 2022).
Piano di lavoro
I – Sotto il cielo del Canada (concluso)
II – Altri amori (concluso)
III – Le ambigue bontà (in revisione)
IV – Animali ignari (in revisione)
V – Archiviare il reale (progetto)
VI – Lanterna occidentale (progetto)
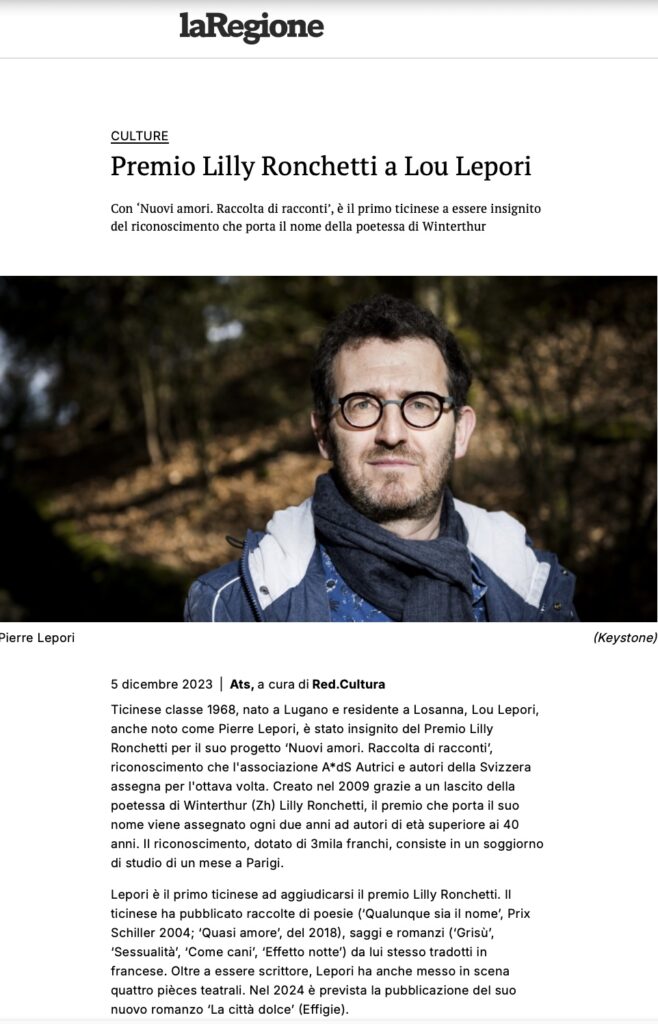
Il en émane une sorte de magie à laquelle il est difficile de se soustraire bien que les phrases se suivent très librement, glissent avec calme et grâce, semblables à une lointaine voix de la mémoire où résonnent encore comme en faible écho les sentiments. Les récits de Lou Lepori finissent par créer un tout nonchalamment esquissé, ouvert et changeant, où prennent forme – pour aussitôt se dissiper – de furtives émotions, d’intenses atmosphères, des moments, des images, des histoires brièvement ébauchées ou mi-secrètes.
Barbara Villiger Eilig, Extrait de la motivation du Jury (Prix Lilly Ronchetti, 2023)
La città vista dall’alto (Montréal) – italien: p.2
Montréal (La ville en bas) – français: p. 3
Intervista inedita con Yari Bernasconi (italiano): p.4

